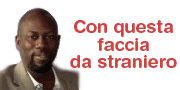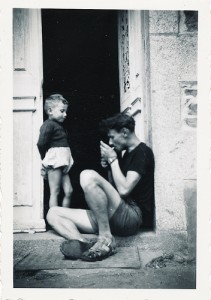 In un assolato pomeriggio estivo dell’ormai tropicale Torino, nella storica società di mutuo soccorso d’ambo i sessi “Edmondo De Amicis”, si discute a partire dal mio Letteralmente femminista. Una donna che si occupa di ricollocazione lavorativa, quel retravaillet che un decennio fa sembrava solo roba da donne che tentavano, dopo la gravidanza, di rimettersi in lista per tornare nel mondo dell’occupazione fuori dalle mura domestiche, interviene.
In un assolato pomeriggio estivo dell’ormai tropicale Torino, nella storica società di mutuo soccorso d’ambo i sessi “Edmondo De Amicis”, si discute a partire dal mio Letteralmente femminista. Una donna che si occupa di ricollocazione lavorativa, quel retravaillet che un decennio fa sembrava solo roba da donne che tentavano, dopo la gravidanza, di rimettersi in lista per tornare nel mondo dell’occupazione fuori dalle mura domestiche, interviene.
Certamente esiste il problema del lavoro femminile, della precarietà, e quello della violenza. Ma vorrei dirvi del problema maschile: nel mio ufficio cominciano ad arrivare, per ricollocarsi, molti uomini, e sono preoccupata di quello che vedo e sento. A differenza di ciò che fanno le donne, che cercano di adattarsi nelle pieghe della crisi, mantenendo comunque inalterata quella capacità di fare acrobazie tra lavoro casalingo, prole, e lavoro fuori, provando persino a ricavare spazi per sé e la socialità, gli uomini arrancano, non negoziano, si irrigidiscono, scoppiano. E sembra che, ancora una volta, tocchi a noi farci carico anche della loro incapacità di cambiare, di mettere da parte l’orgoglio, di assumersi delle responsabilità da adulti, di crescere.
Ho ripensato a questa affermazione quando ho letto l’editoriale di Francesco Merlo su Repubblica, a proposito della seconda morte in auto di bambino dimenticato dal padre, intitolato: “Perché mi sento vicino a quei papà”.
Avevo già sussultato, qualche giorno fa, alle parole della moglie incinta del primo padre che aveva abbandonato la figlia; la donna aveva difeso il marito, sostenendo che quell’uomo del quale si parlava come di un assassino non aveva colpa, che era un buon padre. Mi ero soffermata, con la pelle d’oca e un senso infinito di angoscia, a pensare che non c’era altro modo per una donna di continuare a vivere con un uomo che di fatto ha ucciso la loro figlia, (da lei stessa partorita), soprattutto mentre nutre nella pancia un’altra creatura: l’unica strada per non impazzire era giustificare il suo compagno, continuando a credere in lui e nella sua umanità, opponendo alla disperazione che nemmeno riesco a immaginare una immane forza di volontà di volontà e fiducia che, per me, rasenta l’assurdo.
È possibile che sia più facile scrivere che ci si sente solidali con chi ha fallito, rispetto al sentirsi vicino a chi è vittima e senza colpa. Merlo lo fa benissimo, praticando quel ‘partire da sé’ che quando è menzionato come uno dei doni del femminismo dalle donne viene bollato come pratica non politicamente né socialmente rilevante.
Merlo dice che capisce quell’uomo, che definisce un padre che ha peccato per troppo amore, perché anche lui, spesso, tenta di essere madre oltre che padre della sua prole, e viene colto dal complesso dell’ippocampo, “l’unico animale maschio che prende su di sé la gestazione e si occupa lui delle uova. Ma – continua Merlo- è appunto lì che sta in agguato la disgrazia, nell’avere un cuore troppo grande e due occhi soltanto, nel volere fare quelle mille cose che mia zia ‘la signorina’ avrebbe commentato cosi: “‘mbriachi e picciriddi, centu occhi li devono guardare”.
È ben evidente che quegli occhi dei quali parla la zia signorina sono solo occhi di donne. E che gli uomini non sono capaci di quello sguardo circolare che invece si dà per scontato nelle donne, anche quelle più misere e di poca cultura. Ma se le donne sono così capaci di sguardo circolare e di attenzione, perché sono gli uomini a continuare ad avere il potere, un potere così miope e limitato nello sguardo quando si tratta di tutelare il bene più prezioso?
Credo che non esistano verità facili da esibire di fronte alla morte così insensata di due creature, ma una domanda mi sento di porla: perché il comportamento irresponsabile da parte di un uomo e di un padre può raccogliere così tanta solidarietà da essere addirittura trasformato in un gesto d’amore? Se l’incapacità di un uomo, (e come sembra dall’articolo di Merlo di tutti gli uomini che si provano nella titanica impresa di essere padri), viene definita amore, perché allora non dire che evidentemente c’è un gravissimo problema che gli uomini hanno nell’affrontare la paternità, quella concreta, quella di tutti i giorni? Continuiamo a dare per scontato che la maternità sia connaturata al femminile, ma evidentemente la paternità è ancora ben lontana dall’essere considerata, anche da uomini colti e riflessivi, una condizione che il maschile può pensare come cosciente e possibile.
Al di là della cronaca tragica di questi giorni il tema è importante e ci riguarda come collettività di donne e uomini. È padre non chi feconda con il suo seme una donna, ma un uomo che si assume la responsabilità per la vita della sua prole, come le donne fanno in miliardi nel mondo; chi viene cambiato nel profondo nel diventare tutore, guida, esempio e testimone della figlia e del figlio che la donna che lo accompagna ha generato.
Si potrebbe continuare con le descrizioni che raccontano la paternità, e che purtroppo non sono così frequenti e dettagliate come quelle che dicono il materno, perché l’amara verità è che oltre alla trita storia del ‘mammo’ non ci sono molte moderne narrazioni dell’amore e del ruolo paterno, al di là appunto della banalizzazioni.
Abbiamo alle spalle, e spesso ancora di fronte, le immagini dei padri padroni, ma possiamo davvero dire di avere un’altra dimensione adulta di padri da presentare come altrettanto forte e definita? Gli uomini stanno provando a pensarsi e a dirsi anche padri, oltre a navigatori, santi, eroi, guerrieri, indefessi lavoratori? Non ci può essere crisi economica, non ci può essere eccesso di impegni, non ci può essere alcuna sindrome di ippocampo a motivare una dimenticanza così atroce.
Dai tempi del mito di Ulisse è chiaro che il maschile non riesce ad accettare il senso del limite delle proprie capacità e risorse: il mondo globale ne è prova, e non sarà io a dire che le donne non sono ampiamente conniventi con questo sfacelo. Grande è la anche la responsabilità di molte donne, anche e soprattutto di quelle che continuano a fare il lavoro degli uomini al posto loro, procrastinando così la presa di coscienza maschile autonoma. Sono uomini, che ci si può fare, alcune cose non sono per loro, sembrano dire. È una profezia che si autoavvera: ed è così che i piccoli finiscono abbandonati in auto roventi.
Finché gli uomini non faranno un passo indietro rispetto alla smania superegoica che li allontana dalla materialità della vita e finché non si fermeranno a guardare i loro limiti, quelli del loro corpo e della loro forza non potranno né essere padri e neppure solo uomini. Ingranaggi, forse. Dov’è l’amore in tutto questo?
 Monica Lanfranco è giornalista e formatrice sui temi della differenza di genere e sul conflitto. Ha fondato il trimestrale di cultura di genere MAREA. Ha collaborato con Radio Rai International, con il settimanale Carta, il quotidiano Liberazione, con Arcoiris Tv. Cura e conduce corsi di formazione per gruppi di donne strutturati (politici, sindacali, scolastici). Insegna Teoria e Tecnica dei nuovi media a Parma.
Il suo primo libro è stato nel 1990 "Parole per giovani donne - 18 femministe parlano alle ragazze d'oggi". Nel 2003 ha scritto assieme a Maria G. Di Rienzo "Donne disarmanti - storie e testimonianze su nonviolenza e femminismi" e nel 2005 è uscito il volume "Senza Velo - donne nell’Islam contro l’integralismo". Nel 2007 ha prodotto e curato il film sulla vita e l’esperienza politica della senatrice Lidia Menapace dal titolo "Ci dichiariamo nipoti politici". Nel 2009 è uscito "Letteralmente femminista – perché è ancora necessario il movimento delle donne" (Edizioni Punto Rosso).
Monica Lanfranco è giornalista e formatrice sui temi della differenza di genere e sul conflitto. Ha fondato il trimestrale di cultura di genere MAREA. Ha collaborato con Radio Rai International, con il settimanale Carta, il quotidiano Liberazione, con Arcoiris Tv. Cura e conduce corsi di formazione per gruppi di donne strutturati (politici, sindacali, scolastici). Insegna Teoria e Tecnica dei nuovi media a Parma.
Il suo primo libro è stato nel 1990 "Parole per giovani donne - 18 femministe parlano alle ragazze d'oggi". Nel 2003 ha scritto assieme a Maria G. Di Rienzo "Donne disarmanti - storie e testimonianze su nonviolenza e femminismi" e nel 2005 è uscito il volume "Senza Velo - donne nell’Islam contro l’integralismo". Nel 2007 ha prodotto e curato il film sulla vita e l’esperienza politica della senatrice Lidia Menapace dal titolo "Ci dichiariamo nipoti politici". Nel 2009 è uscito "Letteralmente femminista – perché è ancora necessario il movimento delle donne" (Edizioni Punto Rosso).





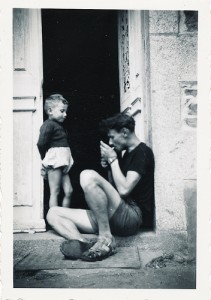
 Monica Lanfranco è giornalista e formatrice sui temi della differenza di genere e sul conflitto. Ha fondato il trimestrale di cultura di genere MAREA. Ha collaborato con Radio Rai International, con il settimanale Carta, il quotidiano Liberazione, con Arcoiris Tv. Cura e conduce corsi di formazione per gruppi di donne strutturati (politici, sindacali, scolastici). Insegna Teoria e Tecnica dei nuovi media a Parma.
Il suo primo libro è stato nel 1990 "Parole per giovani donne - 18 femministe parlano alle ragazze d'oggi". Nel 2003 ha scritto assieme a Maria G. Di Rienzo "Donne disarmanti - storie e testimonianze su nonviolenza e femminismi" e nel 2005 è uscito il volume "Senza Velo - donne nell’Islam contro l’integralismo". Nel 2007 ha prodotto e curato il film sulla vita e l’esperienza politica della senatrice Lidia Menapace dal titolo "Ci dichiariamo nipoti politici". Nel 2009 è uscito "Letteralmente femminista – perché è ancora necessario il movimento delle donne" (Edizioni Punto Rosso).
Monica Lanfranco è giornalista e formatrice sui temi della differenza di genere e sul conflitto. Ha fondato il trimestrale di cultura di genere MAREA. Ha collaborato con Radio Rai International, con il settimanale Carta, il quotidiano Liberazione, con Arcoiris Tv. Cura e conduce corsi di formazione per gruppi di donne strutturati (politici, sindacali, scolastici). Insegna Teoria e Tecnica dei nuovi media a Parma.
Il suo primo libro è stato nel 1990 "Parole per giovani donne - 18 femministe parlano alle ragazze d'oggi". Nel 2003 ha scritto assieme a Maria G. Di Rienzo "Donne disarmanti - storie e testimonianze su nonviolenza e femminismi" e nel 2005 è uscito il volume "Senza Velo - donne nell’Islam contro l’integralismo". Nel 2007 ha prodotto e curato il film sulla vita e l’esperienza politica della senatrice Lidia Menapace dal titolo "Ci dichiariamo nipoti politici". Nel 2009 è uscito "Letteralmente femminista – perché è ancora necessario il movimento delle donne" (Edizioni Punto Rosso).