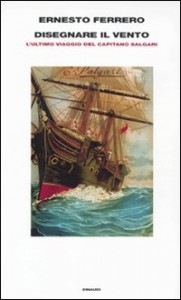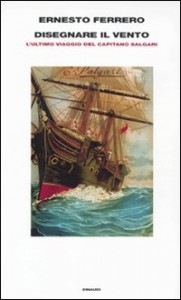 Ho appena finito di leggere Disegnare il vento. L’ultimo viaggio del Capitano Salgari di Ernesto Ferrero (Torino, Einaudi, 2011, 187 pp. 19,50 euro). Si parla di Salgari, dell’ultimo Salgari, degli ultimi due anni di vita del più famoso scrittore italiano di avventure, tesi fra le primavere del 1909 e del 1911, l’anno della morte, uno spettacolare suicidio cui il Capitano e Cavaliere si consegna giusto un secolo fa, per il Suo ultimo viaggio.
Ho appena finito di leggere Disegnare il vento. L’ultimo viaggio del Capitano Salgari di Ernesto Ferrero (Torino, Einaudi, 2011, 187 pp. 19,50 euro). Si parla di Salgari, dell’ultimo Salgari, degli ultimi due anni di vita del più famoso scrittore italiano di avventure, tesi fra le primavere del 1909 e del 1911, l’anno della morte, uno spettacolare suicidio cui il Capitano e Cavaliere si consegna giusto un secolo fa, per il Suo ultimo viaggio.
Il solito libro da anniversario? No. Cioè sì. Ma Salgari è un pretesto; un bel pretesto, anche azzeccato, ma pur sempre un pretesto per parlare d’altro. Di cosa? Di modernità, esposizioni e spaesamenti, di fabbriche e operai, della Fiat, della fotografia, del cinematografo, della cultura e dei suoi gruppi di potere, di chi sta ai margini, delle periferie, di un fiume, del mare, del vento, della vita, che è un soffio, uno schizzo fatto con la punta di un bastone da passeggio sulla terra rossa, sempre sognando sabbie e spiagge lontane. E di libri e di scrittori.
Già, a scanso d’equivoci, meglio dire subito che Ernesto Ferrero, le sue belle ricerchine, le ha fatte, e ne dà conto in una fitta nota bibliografica a fine volume. Di più, non esita, come il Capitano, a nutrire il Suo libro coi libri degli altri e lo dice, sempre attraverso il filtro salgariano: «È normale che sia così, tra scrittori ci si aiuta l’un l’altro, è come cucire una coperta tutti insieme, a stare a fare il conto dei prestiti non si finirebbe più» (p. 110). Ed è una bellissima dichiarazione di poetica, che ritorna altre volte, sempre attraverso la metafora (collodiana più che salgariana) del cucire, del filo di refe, e che spazza via annose e polverose storie di plagi, di mancate citazioni, dalla letteratura alla critica e ancora alla letteratura.
Ecco, in filigrana, Ferrero, la cultura di Ferrero, non è difficile da scovare dietro la vita e le opere di Salgari, ma la posta in gioco è più alta.
Non si tratta solo di uno scrittore che fa il verso a un altro o che presta corpo e penna a un revenant col quale forse condivide una modalità atta a preservare il creato: «Ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa» (p. 77; a chi scrive capitava di dirlo, da sbruffone, in inglese, a proposito della salgariana Cartagine in fiamme, dieci anni fa). E compresi, certo, la «fine del mondo» e i «rari […] miracoli» di una Natura cattivella che regala all’uomo, un paio di volte all’anno, «la goduria delle lucertole» (p. 95).
Poi, da critico (ovvero da artefice di depressioni somme, ad uso e consumo mio e dei poveri lettori di queste righe), potrei dirvi che il libro di Ferrero non è estraneo non solo a quanto Ferrero ha scritto e pubblicato fino all’altro ieri (quasi lapalissiano) ma anche a quel certo romanzesco italiano che ai nostri giorni ospita ritorni/resistenze di autori della modernità dell’Ottocento e del Novecento. Stragettonato, in tal senso, è d’Annunzio, che viene evocato almeno un paio di volte da Ferrero e che è quasi il sublime coscritto di Salgari. Penso a Barbero, ai Di Mino, a Leoni, a Masali, a Marconi et j’en passe.
In entrambi i casi, gli scrittori d’oggi scelgono una postura quasi estrema (e come sempre dilatata per d’Annunzio) che coglie i due grandi autori della letteratura italiana a cavallo del secolo in una sorta di ultimo duello con sé stessi e con la Storia: la Fiume del dannunziano Natale di sangue e il «sangue» del «duello», dello «scontro», della «sua ritualità», sparso da Emilio Salgari in un «burroncello» di Val San Martino (pp. 159 e 177).
Ma oserei di più: ci sono anche i suicidi del Novecento di Eraldo Affinati e, à rebours, il pessimismo di Giacomo Leopardi, storico e cosmico (e via Leopardi, e non solo, affiora anche Giulio Bollati e lo spaesamento psicosociale e antropologico dovuto alla rapidità della modernizzazione). E c’è un «modesto badilante della penna» (p. 111) che è il collante di un libro che è sempre metaletterario e che subito fa scrittura parlando della scrittura e degli scrittori e delle ragioni per cui si scrive: «Si scrive per vivere molte vite. La tua non ti basta, già decisa com’è dal principio alla fine. Si scrive perché ti senti stretto. Perché vuoi essere un altro. Perché vuoi essere considerato e stimato. Perché hai bisogno di qualcuno che ti dica bravo. Perché sei povero. Perché ti vergogni della casa dove stai. Perché non vuoi fare il mestiere che fa tuo padre. Perché non hai i soldi per viaggiare. Per pagarti le donne che vuoi, quelle che vorresti portare al ristorante o all’opera. Perché vuoi fargliela vedere a qualcuno, ai prepotenti, agli invidiosi» (p. 29).
A trascrivere in presa diretta le significative ‘tirate’ del Capitano è una sensibilissima ventenne, Angiolina, che le registra su alcuni quaderni, da cui stralcia l’autore. In fin dei conti, ancora una volta e come da tradizione, un manoscritto. E Manzoni, per di più, finisce per battere d’Annunzio in citazioni ed occorrenze varie. Leggere per credere.
Angiolina, poi, è un diavolo di «pivella», una creatura della crisi travestita da brava ragazza, ingenua e aggressiva a un tempo, e un po’ in odor di Svevo e Pirandello: «Quando ne saprò ancora di più – quando riuscirò a tirare fuori da me anche quello che il capitano non sa di se stesso – sarò persino in grado di attribuirgli un futuro credibile. Potrò portare a compimento il suo destino» (p. 129).
Il Capitano, che in ultimo la ribattezza «Superina», Le scrive una lettera che chiude il volume. E l’attacco della stessa ci conferma quanto sopra suggerito a proposito del romanzesco cui mi sembra partecipare il testo di Ferrero: «in questi mesi e anni ti ho sentita sulle mie tracce come la più astuta delle guerriere pellerossa» (p. 183). Difficile non andare col pensiero a quell’Affinati che è sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer o alle modalità che accampa il suo più recente «pellegrin d’amore».
Certo, Ernesto Ferrero corre meno rischi, e non perché si tratti solo e soltanto di Emilio Salgari. No. Ferrero entra più facilmente in quella cultura, di cui, lo si avverte, è quasi un prolungamento, un prolungamento vitale ma mai figlio di un’immedesimazione un po’ ingenua e ambigua con lo sconfitto, il vinto e con il paradigma che pare ormai farne un significativo, certo, ma troppo gettonato personaggio da romanzo-saggio.
Resta, a mio ‘modico’ avviso, un formidabile ritratto dello scrittore da vecchio, o anziano, se la parola non vi suona. Resta una sorta di magica approssimazione alla vita e allo stile tardi, con citazioni in corsivo e invenzioni in tondo, del grande Salgari, ovvero un elogio inattuale di «una verità umana e poetica».
Luciano Curreri, nato a Torino nel 1966, è ordinario di Lingua e letteratura italiana all'università di Liegi. Tra i suoi lavori più recenti, citiamo "Pinocchio in camicia nera" (Nerosubianco 2008, II ed. corretta e aumentata 2011); "D'Annunzio come personaggio nell'immaginario italiano ed europeo (1938-2008). Una mappa" (Peter Lang 2008); "Mariposas de Madrid. Los narradores italianos y la guerra civil española" (Prensas Universitarias de Zaragoza 2009; ed. or. Bulzoni 2007); "Un po' prima della fine? Ultimi romanzi di Salgari tra novità e ripetizione" (1908-1915) (con F. Foni, Sossella 2009); "L'elmo e la rivolta. Modernità e surplus mitico di Scipioni e Spartachi" (con G. Palumbo, Comma22 2011).