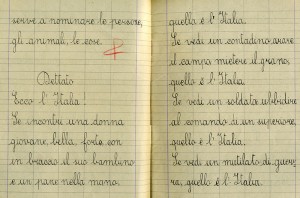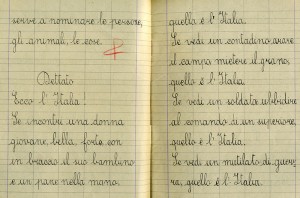 Fin da piccolo, col mio papà, si son viste diverse commedie all’italiana, e non solo quelle notissime. Prima al cine, in periferia, sulla RAI e poi, soprattutto, sulle TV libere. Ricordo le risate di mio padre, che per varie ed eventuali non ha mai riso tantissimo. Rideva a tal punto da piangere, e certe volte piangeva sul serio. Specie quando rivedevamo quelle dedicate al fascismo e alla seconda guerra mondiale. Papà, nato a Torino nel 1936, qualche ricordo lo aveva, e lo tirava fuori a commento. E poi faceva il tipografo e di parole se ne intendeva. Il cinema, allora, era ancora fatto di parole, di molte parole, oltre che di immagini. E il bianco e nero faceva pensare al libro. Ci voleva poco ad amare e a leggere i film come si amavano e si leggevano i libri.
Fin da piccolo, col mio papà, si son viste diverse commedie all’italiana, e non solo quelle notissime. Prima al cine, in periferia, sulla RAI e poi, soprattutto, sulle TV libere. Ricordo le risate di mio padre, che per varie ed eventuali non ha mai riso tantissimo. Rideva a tal punto da piangere, e certe volte piangeva sul serio. Specie quando rivedevamo quelle dedicate al fascismo e alla seconda guerra mondiale. Papà, nato a Torino nel 1936, qualche ricordo lo aveva, e lo tirava fuori a commento. E poi faceva il tipografo e di parole se ne intendeva. Il cinema, allora, era ancora fatto di parole, di molte parole, oltre che di immagini. E il bianco e nero faceva pensare al libro. Ci voleva poco ad amare e a leggere i film come si amavano e si leggevano i libri.
Ricordo benissimo Anni ruggenti (1962) di Luigi Zampa, di cui so quasi tutte le battute a memoria (soggetto di Amidei, Talarico e Zampa, liberamente tratto dall’Ispettore di Gogol, e sceneggiatura di Maccari, Scola e dello stesso Zampa). Un assicuratore viene creduto da tutti gli abitanti di una cittadina pugliese un ispettore in incognito del partito e tutti i “fascisti” si mettono a fare ancor più i fascisti. Un medico d’ospedale, per far bella figura e mostrare la sua fedeltà “filologica” al regime, rimprovera una sua infermiera, responsabile di aver proferito la parola “cachet”, gridando: “Cos’è questo cachet?! Diamogli un italianissimo cialdino”.
In Lingua morta, un articolo risalente al 1943, mai pubblicato e oggi proposto da Andrea Paganini nella sua bella Introduzione a Patria mia, saggio edito in 15 puntate tra il 17 febbraio e il 9 giugno del 1945 nella “Voce della Rezia”, Giorgio Scerbanenco, autore di entrambi i testi, parla di “cialdina”, al femminile, ma il senso non cangia, non muta. Si ride (e si piange) lo stesso.
Come ricorda significativamente Alberto Raffaelli, in Le parole straniere sostituite dall’Accademia d’Italia (1941-43), una ripercussione dei lavori della Commissione per l’italianità della lingua sugli organi professionali, edita in “Il Farmacista italiano”, nell’agosto del 1941, è relativa proprio alla resa di “cachet” in “cialdino”.
Ma quando Scerbanenco, sempre in Lingua morta (e pure in Patria mia) parla della resa del “Lei” in “Voi” non si può non pensare a quanto sia stata scema l’autarchia linguistica del fascio, e fin dagli anni Trenta; e non si può non pensare a un altro capolavoro della commedia all’italiana, Una giornata particolare (1977) di Ettore Scola (qui sopra già ricordato come sceneggiatore di Anni ruggenti, et pour cause).
Le parole sono importanti, diceva un altro giovane regista italiano, ed è bene averne ricordo e coscienza, anche se il “custode del cimitero delle parole morte” immaginato da Scerbanenco non può avere il rigore e il distacco di Alberto Raffaelli – ovvero quello dello storico della lingua verso le parole defunte – perché, dice il poveruomo, “le ho sentite tante volte quando erano vive, e adesso vedermele davanti anche da morte…”. (E in Patria mia troviamo: “Quale inesausto e diabolico filologo vi fosse al ministero…”).
Si ride, leggendo Scerbanenco, che parla giustamente del riso e della chiacchiera come strumenti utili contro il fascismo. Certo, ogni tanto si ha l’impressione che il suo discorso diventi un po’ facile e partigiano, tanto il Nostro cerca di tirar l’acqua al suo mulino, ovvero quello di un uomo di penna che ha intrapreso la via dell’esilio, in Svizzera, dopo l’8 settembre, sostanzialmente per alcuni articoli apparsi sul «Corriere della sera» nel momento della transizione, tra il 25 luglio e l’8 settembre 1943, per l’appunto, e soprattutto per quello che non fu mai pubblicato, Lingua morta (ma è vero che Scerbanenco non poteva saperlo).
Si badi: non si vuol dire che l’esilio (e quello in Svizzera in particolare, dove convergono più di 40.000 italiani) fosse una cosa facile e/o un atto di viltà. Anzi, in genere, come è noto, ma meglio ripeterlo, a scanso d’equivoci, in esilio ci andava chi più si era esposto contro il fascismo (e, se volete, contro il neofascismo della RSI) o chi rischiava la pelle (ebrei, antifascisti, soldati che non volevano obbedire ai nazisti dopo l’8 settembre…).
Quello che non gira del tutto nel discorso di Patria mia è che l’uomo d’Italia che Scerbanenco ha in testa finisca per dar voce a un alquanto generico popolo italiano che si pretende non sia mai stato fascista, e fin dalla prima metà degli anni Venti, a suo dire.
Tale dissociazione, un vero refrain di quegli anni e anche di tanti successivi, la conosciamo bene, specie se praticata da un certo milieu, più o meno colto, borghese, sempre degno, anche nel silenzio (prima) e nell’esilio (poi). Certo, Scerbanenco lo dice: a pagare son sempre gli stessi, “il contadino ferrarese o il meccanico d’Ivrea”. E qui, quello che forse vorrebbe essere un allargamento meno astratto del suo discorso è condotto in modo ambiguo.
Tradotta, tale modalità, implica tale discorso: all’uomo del popolo, all’uomo comune, che magari non si interessava tanto di politica, toccava comunque pagare per gli errori altrui e sopportare l’orrore della guerra. In tal senso, tuttavia, mentre il Nostro (Scerbanenco o il suo alter ego poco importa) resta a discutere in casa con un moderato e un comunista, arrivando alla conclusione che già discutere, nell’intimità, è una conquista, il contadino ferrarese o il meccanico d’Ivrea (o, aggiunge, “il riparatore di biciclette di Porta Tenaja a Milano o il ‘burino’ romano”) sono inviati in Russia e in quella lontana contrada (o in altre) finiscono per fare la guerra con “le uniche, le sole, le povere idee che racimolavano affannosamente da soli per presentarsi davanti alla morte”. E insiste, più greve che ambiguo: “Perché nessun uomo, per rozzo che sia, può morire senza darsi una spiegazione, anche falsa”, ovvero “attaccarsi allo spirito di corpo […] oppure a un’astratta gloria del soldato italiano, un Soldato Italiano al di sopra, ben al di sopra del fascismo, e che non indietreggia mai, e che canta Il Piave mormorò“.
A costo di apparirVi, cari Lettori, un po’ ambiguo io stesso, io che ho fatto il servizio civile, Vi dico che ad essere astratta non è tanto la gloria dei nostri caduti (o dispersi) in Russia quanto l’argomentazione di Scerbanenco: un’argomentazione che, a ridosso della fine del fascismo, sposa una requisitoria che si vuole astratta quando è tesa a deresponsabilizzare una buona, degna e colta parte del popolo italiano, mentre diventa rozzamente concreta quando parla del popolo tout court.
E questo dispiace. Forse, accettare di essersi contaminati e di contaminarsi con la vita, con il contesto storico che ci accoglie e che ci fa parlare, pubblicare o ci silenzia, è e sarebbe stata ancora la scelta migliore.
Del resto, perdonatemi, ma non basta scrivere romanzi polizieschi, anche ottimi, e in genere invisi al regime, per essere davvero impegnato contro il fascismo, magari via metafore ardite o fragorosi silenzi, come ormai ci ricordano a ogni ristampa di un giallo di Scerbanenco; e pensiamo per esempio, in tal senso, e restando negli anni che ci interessano, a quanto suggerisce Roberto Pirani nel saggio che accompagna la riproposta di La bambola cieca (1941), nel 2008, da Sellerio, dove si tramuta la “letteratura d’evasione” – preferita da quel “popolino incolto e immaturo” che il regime osservava stupito e voleva domare con la “mistica fascista” – in “modo di sopravvivere e di resistere”.
Dispiace dirlo ma fatemelo dire, chiedere, esclamare: ma quanto è stato ed è strattonato questo povero “popolino incolto e immaturo” d’Italia?!
Luciano Curreri, nato a Torino nel 1966, è ordinario di Lingua e letteratura italiana all'università di Liegi. Tra i suoi lavori più recenti, citiamo "Pinocchio in camicia nera" (Nerosubianco 2008, II ed. corretta e aumentata 2011); "D'Annunzio come personaggio nell'immaginario italiano ed europeo (1938-2008). Una mappa" (Peter Lang 2008); "Mariposas de Madrid. Los narradores italianos y la guerra civil española" (Prensas Universitarias de Zaragoza 2009; ed. or. Bulzoni 2007); "Un po' prima della fine? Ultimi romanzi di Salgari tra novità e ripetizione" (1908-1915) (con F. Foni, Sossella 2009); "L'elmo e la rivolta. Modernità e surplus mitico di Scipioni e Spartachi" (con G. Palumbo, Comma22 2011).