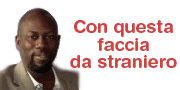Luca scrive nel suo Vangelo che gli occhi sono la lanterna del viso: ci illuminano. Se la morte li prende, li strappa, restiamo al buio, non ci siamo più. La morte è sempre ritratta come un teschio dalle occhiaie vuote: ha bisogno degli occhi dei vivi. Se guardiamo le immagini dei bambini del Darfur, della Somalia, dalle pance gonfie di fame e di miseria e dagli occhi neri, immensi, di solitudine senza difesa; se guard! iamo quelli dei giovani, delle donne, dei ragazzi che sb arcano a Lampedusa; se ci fermiamo (basta un attimo!) sulla profondità della loro luce, se, se, se… scopriamo nello stesso tempo anche la nostra paura, le nostre speranze, la nostra miseria. Quegli occhi non illuminano soltanto quei visi sconosciuti, ma anche i nostri che pure crediamo di conoscere.
Luca scrive nel suo Vangelo che gli occhi sono la lanterna del viso: ci illuminano. Se la morte li prende, li strappa, restiamo al buio, non ci siamo più. La morte è sempre ritratta come un teschio dalle occhiaie vuote: ha bisogno degli occhi dei vivi. Se guardiamo le immagini dei bambini del Darfur, della Somalia, dalle pance gonfie di fame e di miseria e dagli occhi neri, immensi, di solitudine senza difesa; se guard! iamo quelli dei giovani, delle donne, dei ragazzi che sb arcano a Lampedusa; se ci fermiamo (basta un attimo!) sulla profondità della loro luce, se, se, se… scopriamo nello stesso tempo anche la nostra paura, le nostre speranze, la nostra miseria. Quegli occhi non illuminano soltanto quei visi sconosciuti, ma anche i nostri che pure crediamo di conoscere.
Gli occhi che non conosciamo sono quelli della morte: dei malati con le palpebre abbassate nell’attesa o sottoposti alle maschere dell’ossigeno per le ultime ore. Ma anche quelli dei soldati ignoti il cui viso resta nascosto dietro i travestimenti di tubi e di elmetti mentre su un aereo, su una nave, su ! un mezzo lanciamissili premono un pulsante per seminare la morte davanti a loro, per strappare gli occhi ai vivi. Conoscere gli occhi è amare una persona. La guerra non vuole conoscere gli occhi, punta sulle vuote occhiaie della morte.
«Verrà la morte e avrà i tuoi occhi». Lo scrittore Cesare Pavese (1908-1950) ricordava in una breve poesia un amore infelice in cui gli occhi erano tutto: «questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo», scriveva: «I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola! ti pieghi nello specchio. O cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla».
Il fragore della società fa dimenticare chi soffre, non solo: fa dimenticare che si può soffrire, che, premendo un pulsante, spegniamo gli occhi di un Uomo. Ho seguito la fine di un giovane amico: all’inizio dell’inverno gli avevano predetto tre mesi di vita. Stava bene, si sentiva forte, era un po’ pallido. Un amico medico lo ha invitato a farsi visitare. Era robusto, allegro, arguto, vivace, uomo di fede in sé e in Dio: leucemia mieloide acuta. Nessuno scampo. La morte vedeva i suoi occhi e li voleva per sé. Fosse stato u! n ragazzino forse lo avrebbero salvato con un trapianto, dopo i trenta gli avrebbero concesso qualche anno, poi, a poco a poco, più niente: solo tentativi.
Ricoverato nel Policlinico di una città del nord ha resistito con la forza d’animo che non lascia trasparire nulla. La polmonite e un’infezione agli occhi hanno aggredito la sua vita senza più difese fisiche. Gli restavano la volontà e l’intelligenza. Gli occhi si sono rapidamente trasformati, parevano piccoli pomodori marci, in un viso sempre pronto al sorriso.
L’ultima settimana faticava a parlare. Ha voluto un’arancia, spicchio dopo spicchio l’ho aiutato a trovare le labbra assetate con le sue stesse mani incerte. I medici poi l’hanno protetto con le maschere per l’ossigeno. Me l’aveva detto giorni prima, quando ancora gli occhi azzurri vedevano la bianca camera d’ospedale e i congegni elettronici cui era attaccato: «Mario, sto per morire». Ho pensato a tutto. Così come ora penso alla nuova guerra scoppiata solo per il potere dei soldi. Quanti occhi si prenderà la morte. Voleva morire di maggio, con i fiori. Si & egrave; spento una notte di marzo. Il giorno dopo c’era una bella giornata di sole.
Mario Pancera, giornalista e scrittore. Tra i suoi libri, una testimonianza diretta e affascinante su Don Mazzolari, parroco dalla parte dei contadini diseredati: “Primo Mazzolari e Adesso: 1959- 1961” ('Adesso' era il giornale che Mazzolari pubblicava). Ultimo lavoro di Pancera “Le donne di Marx”, edizioni Rubettino