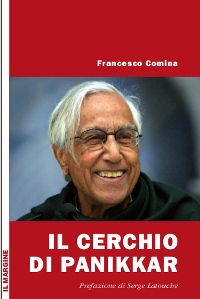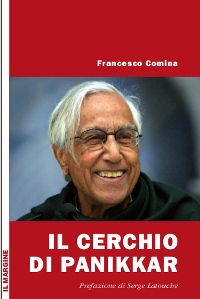 «Perché Jaweh, distruggendo il sogno di Babele, non ha voluto un governo mondiale, un mercato mondiale, una banca mondiale, una democrazia mondiale? Perché ha preferito, per permettere agli uomini di comunicare, delle piccole capanne a misura d’uomo, con finestre e strade, e non delle autostrade dell’informazione? […] Per il filosofo, (la risposta) è affinché i rapporti umani restino personali».
«Perché Jaweh, distruggendo il sogno di Babele, non ha voluto un governo mondiale, un mercato mondiale, una banca mondiale, una democrazia mondiale? Perché ha preferito, per permettere agli uomini di comunicare, delle piccole capanne a misura d’uomo, con finestre e strade, e non delle autostrade dell’informazione? […] Per il filosofo, (la risposta) è affinché i rapporti umani restino personali».
Non so se si trovi la parola “pluriversalismo” nei testi pubblicati da Raimon Panikkar. Non l’ho mai trovata. In compenso, l’idea è ben presente, attraverso l’analisi dell’irriducibile diversità culturale e dell’imposizione dell’universalismo occidentale. Appare ancora più esplicitamente attraverso espressioni come “pluriprospettivismo”.
Ricordo perfettamente di aver sentito il nostro amico denunciare quello che oggi chiameremmo “il pensiero unico” dell’uni-versum (un solo lato, girato verso l’uno) e sostenere il pluri-versum, un mondo plurale e addirittura pluralista. «Ci si chiederà – egli scrive – se ciò che conviene sia l’universitas o piuttosto una pluriversitas».
Il fatto è che per lo più egli si accontenta di utilizzare il vocabolo più ambiguo di “pluralismo”. Tuttavia, come gli capita talvolta di precisare, non si tratta dell’incontestabile pluralità de facto delle società contemporanee, ma di un pluralismo de jure che fatica tanto a imporsi. «Per pluralismo – spiega – io intendo la presa di coscienza della coesistenza legittima dei sistemi di pensiero, di vita e di azione che, presi nel loro insieme, sono tra loro incompatibili». «Pluralismo – osserva pensando in realtà al pluriversalismo – non significa semplice tolleranza dell’altro. Pluralismo significa l’accettazione della nostra contingenza, il riconoscimento che né io né noi abbiamo dei criteri assoluti per giudicare il mondo e gli altri. Pluralismo significa che ci sono dei sistemi di pensiero incompatibili tra loro o, utilizzando una metafora geometrica, incommensurabili (come lo sono il raggio e la circonferenza o l’ipotenusa e il cateto, pur restando tuttavia in coesistenza o co-implicazione)».
Con il “pluriversalismo”, infine, si tratta di promuovere una democrazia delle culture, per riprendere un’altra delle sue espressioni. Questo pluriversalismo, Raimon Panikkar lo incarna in se stesso. Nato a Barcellona nel 1918 da madre spagnola e padre indiano, egli ha studiato, vissuto e poi insegnato in Spagna, Germania, Italia, India, America Latina e Stati Uniti. Dottore in filosofia, scienze (chimica) e teologia, egli ha sviluppato, come Pico della Mirandola un’apertura su “tutte le materie conoscibili” e perfino qualche altra… Tuttavia, i suoi insegnamenti di filosofia delle religioni si sono sempre incentrati sul problema dei rapporti tra le culture: «Sono stato cresciuto, dice Panikkar, nella religione cattolica da mia madre, spagnola, ma non ho mai smesso di cercare di raggiungere la religione tollerante e generosa di mio padre e dei miei avi indù […]. Mi sento al 100% indù e indiano, al 100% cattolico e spagnolo. Come è possibile? A condizione di vivere la religione come un’esperienza e non come un’ideologia».
Ciò che egli propone è dunque non una sorta di ibridazione di culture e nemmeno un dialogo interculturale ma un dialogo “intraculturale”. «Se non trovo in me il terreno in cui l’indù, il musulmano, l’ebreo, l’ateo, l’altro possano avere uno spazio – nel mio cuore, nella mia intelligenza, nella mia vita – non potrò mai entrare in un vero dialogo».
In effetti, come suggerito da Dominique Janicaud, trasponendo il teorema ben noto di Gödel, non esiste la cultura di tutte le culture, poiché non esiste l’insieme di tutti gli insiemi. Perché una cultura esista, è necessario che ne esistano almeno due, dato che la cultura si definisce sempre come relazione. Si costruisce per assimilazione degli apporti esterni e per differenziazione rispetto alle altre culture. «Le differenti culture del mondo – scrive un commentatore di Panikkar – sono come quelle persone che, sporgendosi dalla finestra del loro salotto, possono vedere l’interno della stanza da cui parla il loro interlocutore come fossero dall’altra parte della strada, ma non quello della loro, dato che gli voltano le spalle».
«Il mito della Torre di Babele – scrive Panikkar – è il sogno di un linguaggio unico. Invece di desiderare di ricostruire una nuova torre noi possiamo forse costruire delle vie di comunicazione e perfino di comunione tra le differenti capanne dei nostri mondi limitati».
Anche se domani la globalizzazione trionfasse, non sarebbe l’apoteosi di una cultura di tutte le culture. «La tecnocrazia, per dirlo in una parola, si è praticamente diffusa ai quattro angoli del pianeta. Bisogna forse superarla o dominarla, ma non si può ignorarne l’ubiquità. Sarà forse destinata a essere la cultura unica che si sostituirà alle altre: questo non significa tuttavia che essa sia una supercultura che ingloba tutte le altre». (…).
È paradossale, forse inappropriato, o addirittura scorretto, da parte di un intellettuale ateo pretendere di dare una interpretazione come di un pensiero secolare, l’opera di un teologo cattolico. Specialista dello sviluppo e della problematica della diversità culturale, mi sono spesso confrontato con “sacerdoti” o ex sacerdoti, cattolici o protestanti, teologi o pastori della Chiesa riformata, come Jacques Ellul et Gilbert Rist, ex padre bianco, come Michael Singleton, preti più o meno di rottura, come Ivan Illich, Robert Vachon, Alex Zanotelli, Marc Luycks e molti altri. Mentre Michael Singleton, partito per convertire i pagani in Tanzania, si è piuttosto lasciato convertire al paganesimo dai suoi Wakonongo, Panikkar, partito cristiano, si è ritrovato indù e ne è tornato buddista (senza, peraltro – precisa – aver mai smesso di essere cristiano).
Essendo stato presentato come «un pagano che ha la fede», forse dopo tutto io stesso sono predisposto a trasmettere ai miei lettori, in una forma profana, dei messaggi prodotti in altre parrocchie.
Resta il fatto che questa interpretazione di una “teologia” laica mi pare legittima per far capire una parola più che mai necessaria, quella della tolleranza vera e del dialogo autentico tra gli uomini, tra i popoli, tra le culture, tra i credenti e tra i non credenti.
In Italia Raimon Panikkar ha avuto maggiore fortuna rispetto alla Francia. In molti ambienti i suoi libri, le sue riflessioni, le sue visioni hanno fatto scuola. Sta uscendo l’opera omnia. Sono apparsi libri e articoli sul suo pensiero. Per i novant’anni si è tenuto a Venezia nel 2008, nell’ambito dell’università, un importante simposio con interventi di studiosi. In vista del primo anniversario dalla morte (26 agosto 2010) stanno uscendo sul mercato editoriale alcuni libri che rileggono, con tagli differenti, le intuizioni di questo grande pensatore.
Il libro di Francesco Comina ha il merito di ricostruire le affascinanti intuizioni di Panikkar intrecciando i fili di una amicizia che rende il racconto più immediato e, a tratti – come per il dialogo ultimo in cammino verso il monte della mistica – perfino poetico.
In fin dei conti, quello che conta nella vita non è tanto il logos, la razionalità, come insegnava il nostro amico, quanto l’essere, la vita, la relazione di volti. La saggezza dell’amore è stare in questo mondo secondo un ritmo circolare, non correre ansimando lungo l’autostrada del tempo lineare.
Il cerchio di Panikkar ci indica un cammino possibile.
(Questo testo è l’introduzione del libro Il cerchio di Panikkar di Francesco Comina, editrice Il Margine)
Serge Latouche (Vannes, 12 gennaio 1940) è un economista e filosofo francese. Professore emerito di Scienze economiche all'Università di Parigi XI e all' Institut d'études du devoloppement économique et social (IEDS), teorico della “Decrescita”, è uno degli animatori de La Revue du MAUSS, presidente dell'associazione «La ligne d'horizon». Tra i suoi libri tradotti in italiano: “L'altra Africa. Tra dono e mercato” (Bollati Boringhieri, 1998), “La scommessa della dcrescita” (Feltrinelli, 2007).