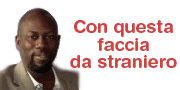Ogni quattro anni, escono i clandestini e io con loro. Ogni quattro anni, per un mese, puntualmente, tiro i remi nella barca attraccata al molo della routine e vi rileggo, Eduardo dell’Uruguay e Ryszard della Polonia, per cercare di capire perché una grande fetta di questa umanità bislacca, in perenne conflitto si ritrovi, unita, dentro uno stadio. A dipingersi il volto come pagliacci, a gridare come cretini avvolti in una bandiera, a fare onda, a tremare guardando l’orologio, a imprecare, a piangere. A pregare, soprattutto.
Welcome world, it’s time: è Mondiale, finalmente. Tempo di suppliche accorate, strozzate in gola. Fatte di nascosto, dietro le colonne del pudore. Gli ex voto sono segreti, si appendono nella cripta, a occhi bassi. Attorno, sventolano le bandiere, assordano le vuvuzela, i razzi, i tamburi, piovono i coriandoli; Johannesburg sparisce, gli Achille omerici e gli El Cid si chiamano Cristiano Ronaldo e Rooney, la routine si dimentica, solo esiste il tempio. In questo spazio sacro, l’unica religione che non ha atei, esibisce i suoi dei.
L’altare è un maxischermo, invaso da colori e suoni. L’officiante di turno, in questo caso, si chiama Bafana Bafana, mister Orgoglio Africano. Ha come accoliti i volti più famosi e coinvolgenti di tutto un continente che si fa stoffa sul prato verde. Bisnonno Madiba Mandela, l’assente più presente del tempio, ricorda che “chi ha il coraggio non deve avere la paura di perdonare”.
Voci, come i venti di mare e di scoglio, di savana e foresta, di deserto e di oasi: Miriam Makeba, Kandisha Mazwai, Femi Kuti e Khaled con la sua “Didi”. Africa, che si fa albero della vita, componendo un baobab sul campo da gioco. Baobab da cui sbuca Shakira, i fianchi in calore di femmina latinoamericana e mediorientale, affanno di Dioniso, morso di Eva, ombelico della gioventù che esplode irridente e vincitrice.
E, dietro, possono uscire allo scoperto i clandestini d’Italia, gli immigrati che cercano su un maxischermo milanese la bandiera della propria patria lontana. Non c’è quella del Perù. Non importa, c’è quella dell’Argentina. Non c’è quella della Bolivia, chi se ne frega: c’è quella del Brasile. Mancano Guatemala e Panama: W Mexico! Qualcuno scriva al generale Bolivar che il suo sogno degli Stati Uniti dell’America del Sud si è realizzato nello stadio Soccer City. Non ci sono le 7 mila isole delle Filippine cattoliche, lascia perdere: gioca la Corea comunista del Nord e il Giappone capitalista: insomma qualcuno c’è a rappresentare il Bangladesh.
Agitano un fazzoletto (contro la xenofobia?), ogni giorno deglustiscono saliva, in questura, per il permesso di soggiorno a punti. Ingoiano veleno nei cantieri edili e nelle concerie puzzolenti, ma ora si mangiano il berretto, sussurrano preghiere e maledizioni, e improvvisamente si rompono le corde vocali: hanno visto Messi, il nuovo 10 dopo quello di Maradona, il “maledetto” che conosce il fetore della periferia, il loro specchio, quello che ha varcato la porta dell’inferno, sfiorato la morte ed è stato toccato dalla mano de Dios. Chi sarà stavolta il nuovo Pelè, zorro nero, latino vendicatore degli oppressi della Sierra Madre e delle badanti di via Padova? Lo scugnizzo Robinho o Kakà, il consacrato di una setta evangelica?
Algeria, Camerun, Costa d’Avorio, Nigeria, Ghana e Sudafrica, cosa potranno contro i Golia d’Europa – la geometria dei panzer ariani, la furia dei tori spagnoli, l’eterna puzza sotto il naso degli Asterix, il pallore imperiale della perfida Albione -, colonialisti riciclati nelle acque della globalizzazione? Alle donne d’Africa, che guardano con me lo spettacolo dei Mondiali nel maxischermo della piazza Trocadero, non importano i goal. Per loro quello che conta è vedere che in tutte le squadre ci sono giocatori famosissimi dalla pelle nera, figli degli schiavi moderni, i migranti, ritornati, dopo anni di clandestinità, nell’umido baobab delle origini primigenie.
Mentre dura la Messa pagana, ogni immigrato non si sente più solo, è moltitudine, rappresenta tutta la sua gente. La sente vicina. L’oceano della distanza si annulla, condivide la certezza che “questa volta è la volta buona”, che “la coppa del mondo ci è dovuta”, che “siamo i migliori”, che tutti gli arbitri sono dei venduti cornuti e che tutti i rivali sono degli imbroglioni mafiosi. Non dicono “oggi gioca la mia squadra”. Ma “oggi giochiamo noi”. E, tutti insieme, costituiscono il giocatore numero dodici che è quello che emette folate di tifo che spingono il pallone quando questo si addormenta. E lo sanno bene gli altri undici giocatori, che giocare senza tifosi è come ballare senza musica.
In cosa assomiglia il football a Dio? Risponde Eduardo Galeano: nella devozione che gli dimostrano molti credenti e nella diffidenza che gli ostentano molti intellettuali. Ma lui, intellettuale socialmente impegnato e costretto dalle dittature alla clandestinità dell’esilio, ama l’urlo del calcio come il richiamo della vita: “Tutti noi dell’Uruguay siamo nati gridando ” goal”; per questo c’è tanto rumore nelle maternità, uno strepito tremendo”.
Kapuscinski ci trascina in giro per il mondo. Coltivando pietas anche per chi viene strumentalizzato politicamente attraverso il calcio. In La guerra del football ed altre guerre di poveri, racconta come nel 1969 la tensione creata da una partita di football tra le squadre nazionali di El Salvador e l’Honduras (eliminatorie del mondiale Messico ’70) faccia esplodere una tensione ben più profonda, causata dall’emigrazione di centinaia di migliaia di salvadoregni, alla ricerca di terra e sopravvivenza in Honduras. Dopo 6 giorni di bombe e mitraglia, si contano circa 5700 morti: tra i soldati rimangono uccisi un centinaio di salvadoregni e circa 2000 honduregni, mentre tra i civili perdono la vita circa 3000 honduregni e 600 salvadoregni. Oltre 50.000 sono gli sfollati.
La guerra termina con una tregua e con il sostanziale mantenimento dei confini preesistenti, ma i due Stati si dichiarano soddisfatti: per qualche giorno, infatti, i giornali di tutto il mondo hanno parlato di loro. “I piccoli stati del Terzo, Quarto e di tutti gli altri mondi possono sperare di suscitare qualche interesse solo quando decidono di spargere sangue. Triste ma vero,” conclude Kapuscinski.
Ignobile partita, quella che certi potenti hanno saputo far giocare ai propri connazionali, insozzando di sangue, di slogan e di milioni, un confronto che altri – più sanamente democratici- vivono freudianamente tra le pieghe delle lenzuola: “Il goal è l’orgasmo del football. Come l’orgasmo, il goal è ogni giorno meno frequente nella vita moderna delle città”.
Sarà per questo che il commentatore sportivo latinoamericano, notoriamente urbano, quando succede il “miracolo” del goal, urla in forma spasmodica per molti minuti, peggio della vuvuzela: gooooaaall? Lo assumono non perché se ne intende di schemi 4-4-2 o di spostamenti sulle fasce, di cui ci intontisce Marcello Lippi. Lo assumono per il più primordiale “do di petto” che abbia rimbombato nella savana africana, quello con cui il primate dominante riafferma, nel meriggio della libidine sotto l’ombra del baobab, il suo trionfo sessuale. L’entusiasmo che si stappa ogni volta che il pallone scuote la rete può sembrare un mistero o una pazzia, la moltitudine delira e lo stadio si dimentica che è di cemento, si stacca dalla terra e se ne va all’aria.
Per i meno lussuriosi – come mi sembra siano gli immigrati senza nome con i quali condivido questa notte non più clandestina dei Mondiali – rimane una prece selvatica. La riporta Kapuscinski, allegando una preghiera che, prima di una partita di calcio, un gruppo africano rivolge a Dio e che contiene una precisazione importante che ognuno di noi fa propria i attesa che la rispettiva formazione nazionale faccia il suo ingresso in campo:
Dio, ora, affronteremo una nuova battaglia, grande davvero. Sarà una battaglia dura, non roba da bambini. Perciò, ti prego, non mandarci in aiuto tuo Figlio, vieni Tu.
 Specialista in cooperazione internazionale. Autrice di "Romanzo di frontiera" (Albatros, Roma 2011), magia e realtá delle donne latinoamericane alla frontiera Messico-USA; "In Amazzonia" (Milano, Feltrinelli, 2006); "La Ternura y el Poder" (Quito, Abya Yala, 2006); "Una canoa sul rio delle Amazzoni: conflitti, etnosviluppo e globalizzazione nell'Amazzonia peruviana" (Gabrielli Editore, Verona, 2002); co-autrice di "Prove di futuro" (Migrantes, Vicenza, 2010).
Specialista in cooperazione internazionale. Autrice di "Romanzo di frontiera" (Albatros, Roma 2011), magia e realtá delle donne latinoamericane alla frontiera Messico-USA; "In Amazzonia" (Milano, Feltrinelli, 2006); "La Ternura y el Poder" (Quito, Abya Yala, 2006); "Una canoa sul rio delle Amazzoni: conflitti, etnosviluppo e globalizzazione nell'Amazzonia peruviana" (Gabrielli Editore, Verona, 2002); co-autrice di "Prove di futuro" (Migrantes, Vicenza, 2010).





 Specialista in cooperazione internazionale. Autrice di "Romanzo di frontiera" (Albatros, Roma 2011), magia e realtá delle donne latinoamericane alla frontiera Messico-USA; "In Amazzonia" (Milano, Feltrinelli, 2006); "La Ternura y el Poder" (Quito, Abya Yala, 2006); "Una canoa sul rio delle Amazzoni: conflitti, etnosviluppo e globalizzazione nell'Amazzonia peruviana" (Gabrielli Editore, Verona, 2002); co-autrice di "Prove di futuro" (Migrantes, Vicenza, 2010).
Specialista in cooperazione internazionale. Autrice di "Romanzo di frontiera" (Albatros, Roma 2011), magia e realtá delle donne latinoamericane alla frontiera Messico-USA; "In Amazzonia" (Milano, Feltrinelli, 2006); "La Ternura y el Poder" (Quito, Abya Yala, 2006); "Una canoa sul rio delle Amazzoni: conflitti, etnosviluppo e globalizzazione nell'Amazzonia peruviana" (Gabrielli Editore, Verona, 2002); co-autrice di "Prove di futuro" (Migrantes, Vicenza, 2010).