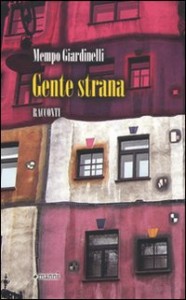
Non l’ho mai raccontato prima d’ora e in questo preciso momento non saprei spiegarne il motivo. Credo fosse alla fine del 1980. Ero in volo da Città del Messico a New York. Sul mio stesso aereo viaggiava Jorge Luis Borges, sebbene lui si trovasse, ovviamente, in prima classe. A un certo punto mi feci coraggio e chiesi alla hostess il permesso di sedermi al suo fianco per alcuni minuti. Acconsentì con la proverbiale simpatia delle messicane e mi offrì perfino un bicchiere di vino.
Borges teneva gli occhi chiusi e sul suo grembo era adagiata una cartelletta in cuoio di vitello rosso cardinale. Sembrava pregare ma, trattandosi di Borges, si poteva supporre che stesse componendo o recitando un poema. Fu molto cordiale con me e quando mi presentai come suo compatriota, disse sorridendo:
«Forse non è un caso che noi, due argentini, ci incontriamo a questa altezza. Beh, entrambi sappiamo quanto ci costa mantenere i piedi sulla terra.»
Mi domandò in cosa potesse essermi utile e io gli risposi che semplicemente non volevo lasciarmi sfuggire l’occasione di salutarlo e, in breve, gli raccontai che avevo appena pubblicato un racconto intitolato L’intervista in cui immaginavo che lui, Borges, arrivasse all’età di 130 anni senza vincere il Premio Nobel e un editore nordamericano dalla voce melliflua incaricasse me, a quel tempo un vecchio cronista di più di ottant’anni in pensione, di intervistarlo.
Naturalmente Borges non si interessò alla mia prosa ma mi chiese ragguagli sul mio interesse per lui: volle sapere cosa avessi letto delle sue opere o, almeno, quali conoscessi. Compresi che gli importava distinguere un ammiratore da un lettore, cosicché gli raccontai di averlo letto per intero grazie a un torneo di scacchi tra scrittori. Senza dubbio lo lusingai e destai la sua curiosità. Quindi gli raccontai la breve storia degli anni durante i quali avevo lavorato nella vecchia casa editrice Abril in cui, oltre a una eccellente scuola di giornalisti, c’erano decine di buoni poeti e narratori e quasi tutti giocavano abbastanza bene a scacchi. Menzionai ovviamente molte penne di valore di quei tempi, al principio degli anni Settanta. Commentai che tutti lo avevano letto e volevano vincere il premio che la casa editrice aveva messo in palio per il campionato di quel funesto 1975: le sue Opere Complete. Però il caso volle (glielo dissi, sapendo che quell’intervento del fato l’avrebbe deliziato) che il campionato e il premio li vincessi io che ero un giovincello infatuato che allora privilegiava la Rivoluzione alla Letteratura e che non l’aveva letto solamente per puro pregiudizio giovanile.
«Forse lei aveva ragione» mi riprese. «Fu l’anno in cui dissi che Pinochet e Videla erano due galantuomini. Uno sproposito di cui oggi mi vergogno.»
Comunque era imperdonabile che, essendo io allora un giovane aspirante narratore, non l’avessi letto e riletto, cosicché gli raccontai che subito dopo avevo rimediato alla mancanza e gli illustrai le mie preferenze. A un certo punto mi interruppe per pregarmi di non sprecare gli elogi e, alla fine, gli confessai che attirava molto la mia attenzione la sua insistenza nel citare testi introvabili come il Necronomicon, la Prima Enciclopedia di Tlön, L’avvicinamento a Almotasim, opere di Herbert Quain quali Il Dio del Labirinto, Aprile Marzo, Lo Specchio Segreto, ecc., e le sue citazioni di altri autori cui era solito riferirsi come Johann Valentin Andre, Mir Bahadur Ali, Julius Barlach, Silas Haslam; Jaromir Hladik, Nils Runeberg, il cinese T’Sui Pen, Marcel Yarmolinski, le confessioni di
Meadows Taylor o le – a suo parere – sempre oscure, incomprensibili idee filosofiche di Robert Fludd.
Borges rise di gusto e mi disse, enigmaticamente:
«Di tutti quei libri solo uno è vero. L’ho scritto io.»
Non potei far altro che fissarlo con lo sguardo, abbagliato da quell’uomo delicato e magro la cui cecità scrutava meglio di nessun altro l’infinito vuoto aldilà dei finestrini mentre, come d’abitudine, accarezzava l’impugnatura del suo bastone.
Egli avvertì la densità del mio silenzio.
«Non è tutto: ho qui una bozza» disse dolcemente, quasi sussurrando. «Vuole darle un’occhiata?»
Mi emozionai, direi, fino a sfiorare le lacrime. Ovviamente gli risposi che accettavo, lo ringraziai per il gesto, dissimulando senza efficacia la mia ansietà, e quando mi allungò la cartella in cuoio di vitello rosso cardinale ritornai al mio sedile nella classe turistica in fondo all’aereo e mi immersi nella lettura. Il testo recava uno strano titolo borgesiano che sinceramente non ricordo con esattezza. Stupidamente credo in maniera vaga che il titolo fosse Il Giuda irregolare o qualcosa di simile. Era un romanzo o ciò che suppongo avrebbe dovuto essere il romanzo di Borges dattiloscritto da qualcuno cui lui lo aveva dettato. La trama era semplice: Egon Christensen, un ingegnere danese di Copenhagen, arrivava a Buenos Aires nel 1942 come capomacchina di un cargo il cui capitano non si azzardava a partire per timore di essere affondato dalle corazzate tedesche che infestavano l’Atlantico del sud. Egon si stabiliva vicino a La Plata, convalidava il proprio titolo di ingegnere e se ne andava a Jujuy, assunto dallo zuccherificio Ledesma. La sua passione erano gli scacchi, ammirava Max Euwe e a Jujuy viveva una peripezia amorosa e un’altra sportiva, entrambe cariche di paradossi.
Le cose straordinarie, senza dubbio, erano la sua prosa, l’infinito rigore dei vocaboli, la struttura precisa e depurata di una sequenza esponenziale, un’inevitabile citazione di Adolfo Bioy Casares, la retorica perfetta e soprattutto l’erudizione che lasciava sbalordito un lettore privilegiato come me.
Quando terminai, tremando d’emozione e riconoscenza, gli riportai la cartelletta. Borges dormiva, con la testa inclinata su una spalla come un bocciolo di cotone spezzato. Mi sembrò inopportuno svegliarlo e inoltre ero così impressionato che sarei stato capace di dirgli solamente stupidaggini. Preferii depositare dolcemente la cartelletta sul suo grembo.
Quando arrivammo all’aeroporto Kennedy, una folla di persone salì sull’aereo per riceverlo (editori o ambasciatori, presumo) e vidi come venne portato in fretta in una sala vip.
Passando i controlli della dogana vidi anche, con spavento, che la stessa cartelletta di cuoio rosso cardinale era nelle mani di un uomo molto alto, biondo, di inconfondibile aspetto scandinavo. Mi sembrò di averlo visto in prima classe, però non ero sicuro e ormai era un dato irrilevante: era evidente che avevano rubato il manoscritto a Borges.
Mi allarmai e non sapevo se denunciarlo gridando oppure correre verso l’uomo per recuperare la cartelletta, visto che ormai non potevo più avvisare né Borges né quanti lo accompagnavano. L’ufficiale della polizia migratoria mi disse qualcosa e il momento dopo persi di vista il danese, perché si trattava di un danese, non c’è dubbio. Sentii uno strano panico che durò tutto il giorno e quelli che seguirono. Lessi con angoscia i quotidiani di tutta la settimana, sperando di trovare una denuncia, il reclamo di Borges o dei suoi rappresentanti. Arrivai perfino a pensare che avrebbe potuto accusarmi di un tale delitto.
Nulla. Non accadde nulla e, che io sappia, egli non pronunciò mai una parola sull’episodio. E io non lo rividi più fino a una notte del 1985, rientrato dall’esilio, quando dalla casa editrice Sudamericana mi invitarono a una conferenza con Borges su un libro di viaggi che aveva scritto con María Kodama. Andai con l’intenzione di chiedergli di quella cartelletta in cuoio di vitello rosso cardinale. Però, a un certo punto, alla prima domanda del pubblico, raccontò che una volta, durante un viaggio in aereo, aveva sognato che un tizio gli si avvicinava dalla classe turistica e lui lo ingannava affidandogli un testo apocrifo che quell’uomo non gli rese mai più.
Ovviamente, scelsi di restare in silenzio. Borges morì qualche tempo dopo, come tutti sanno, a Ginevra.
(Questo brano è tratto dal libro Mempo Giardinelli, Gente strana, Manni Editore. In “Gente strana” – quattordici racconti mai tradotti in italiano – l’autore ritrae il dolore della memoria, gli inferni della colpa, i sogni frustrati, l’invidia, l’erotismo delle città della provincia argentina. In queste pagine si affacciano l’aura borgesiana e lo splendore abbagliante dei momenti più intensi della storia e della cultura argentina. Gente strana vive di un delizioso gioco di equilibrio tra gli odi, le speranze e le delusioni dei personaggi e la realtà del mondo magico ma al tempo stesso estremamente reale creato da Giardinelli).
 Mempo Giardinelli (1947) è uno scrittore e giornalista argentino tra i più apprezzati a livello internazionale. Nel 1986 ha fondato e diretto la rivista letteraria “Puro Cuento”. Le sue opere sono tradotte in tutto il mondo. In Italia ha pubblicato romanzi e narrativa con Guanda e Tea.
Mempo Giardinelli (1947) è uno scrittore e giornalista argentino tra i più apprezzati a livello internazionale. Nel 1986 ha fondato e diretto la rivista letteraria “Puro Cuento”. Le sue opere sono tradotte in tutto il mondo. In Italia ha pubblicato romanzi e narrativa con Guanda e Tea.





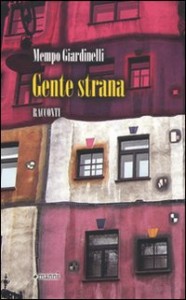
 Mempo Giardinelli (1947) è uno scrittore e giornalista argentino tra i più apprezzati a livello internazionale. Nel 1986 ha fondato e diretto la rivista letteraria “Puro Cuento”. Le sue opere sono tradotte in tutto il mondo. In Italia ha pubblicato romanzi e narrativa con Guanda e Tea.
Mempo Giardinelli (1947) è uno scrittore e giornalista argentino tra i più apprezzati a livello internazionale. Nel 1986 ha fondato e diretto la rivista letteraria “Puro Cuento”. Le sue opere sono tradotte in tutto il mondo. In Italia ha pubblicato romanzi e narrativa con Guanda e Tea.